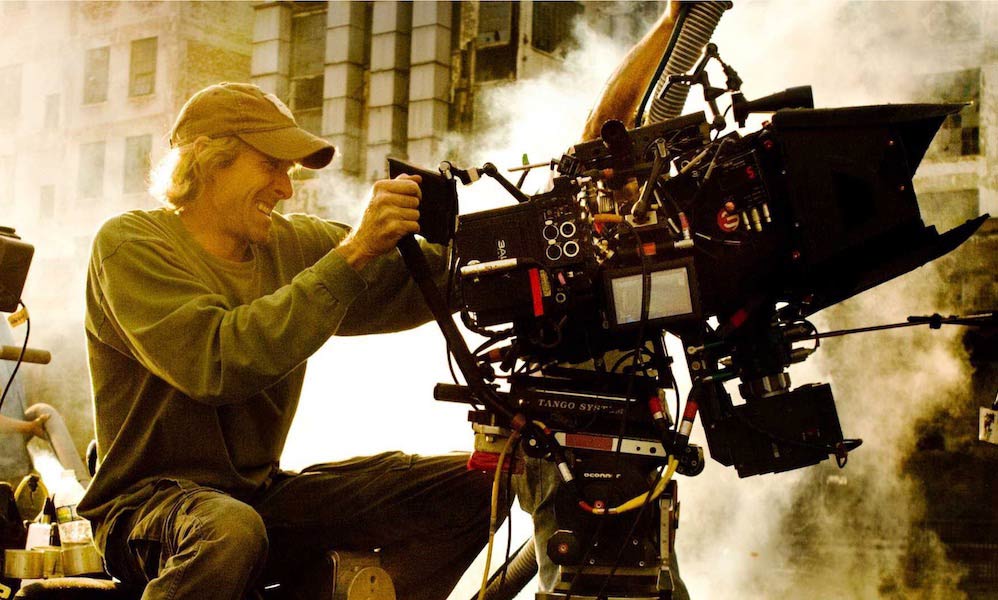Federico Fellini è considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema, nell’arco di quasi quarant’anni, da Lo sceicco bianco (1952) a La voce della luna (1990), ha vinto cinque premi Oscar e dato vita a personaggi memorabili. I suoi film più celebri La strada, Le notti di Cabiria, La dolce vita, 8½ e Amarcord sono entrati nell’immaginario collettivo cambiando il concetto di cinema e influenzando intere generazioni di registi (come racconta Spielberg).
Fellini a sedici anni è già innamorato del cinema, inizia da giovanissimo a disegnare fumetti satirici e a scrivere sui giornali, per poi cimentarsi nella sceneggiatura radiofonica e cinematografica. Roberto Rossellini lo chiama per collaborare a Roma città aperta e continua a lavorare come sceneggiatore con Lattuada, Germi e Comencini.
Il momento cruciale per Fellini è proprio il passaggio alla regia, quando non pensava di fare il regista ma credeva di bivaccare sornione nel limbo della sceneggiatura, irresponsabile e lontano dal lavoro collettivo. Il primo giorno di lavorazione de Lo sceicco bianco (1952) si rivela un fallimento: non riesca a girare neanche un’inquadratura. Parte da Roma all’alba con la sua Cinquecento, con il batticuore come poco prima di un esame, e si ferma a pregare in chiesa perché il portone che si apre gli sembra di buon auspicio.

Sulla strada buca una gomma e soffre al pensiero di essere in ritardo per la sua prima regia, per buon cuore un camionista siciliano gli cambia la ruota ma il coraggio è un servizio extra che non fornisce nessuno. La paura di Fellini è fortissima e mentre il motoscafo lo porta verso il barcone, dove già da un’ora è imbarcata tutta la troupe, non si ricorda neanche la trama del film; ma poi, posa il piede sul set ed è pronto all’avventura.
Lo sceicco bianco è un’opera creata da quelli che sarebbero stati i grandi nomi del cinema italiano: Michelangelo Antonioni è coautore del soggetto, Ennio Flaiano della sceneggiatura e il protagonista è un giovane Alberto Sordi. Il film ha uno stile umoristico e onirico che viene definito fantarealismo. La pellicola esordisce al Festival di Venezia, dove subisce lo snobismo di critica e pubblico, gli stessi che l’anno successivo lo premiano con il Leone d’Oro per I vitelloni.
Fellini nella sua opera prima smonta gli idoli, le illusioni e i fenomeni di costume della borghesia provinciale italiana del dopoguerra. La sua attenzione è però rivolta soprattutto ai sentimenti della protagonista e alla piccola tragedia personale che si compie nel cuore di Wanda, prima che nella vita dei coniugi Cavalli. Wanda (Brunella Bovo) ed Ivan (Leopoldo Trieste), sono in viaggio di nozze a Roma. Lei ne approfitta per recarsi alla redazione del suo fotoromanzo preferito per incontrare il protagonista: lo Sceicco bianco (Alberto Sordi).

Wanda capisce presto che il suo idolo è un uomo patetico e volgare e ne respinge le pesanti avances. Afflitta tenta di gettarsi nel Tevere ma viene salvata, mentre Ivan la cerca per tutta Roma e vive delle rocambolesche avventure che lo portano a dormire con una prostituta – senza però tradire la moglie. I due alla fine si ritrovano, un po’ disillusi e senza eroi.
In questa pellicola è palese la nostalgia felliniana per le icone popolari, che sempre l’hanno sedotto, La vita vera è quella dei sogni dice una signora alla spaesata Wanda e, man mano che la giovane vede il suo sogno svanire, le luci si fanno opache e Fellini ci mostra le bassezze di chi si preoccupa dell’onore, delle conoscenze in Vaticano e della retorica patriottica, prima che dei sentimenti.
Lo Sceicco Bianco è una commedia nel senso più stretto del termine, tratta il dramma umano, quello risibile, che racconta le illusioni e le spoglia e permette di grattare oltre la superfice della satira ecclesiastica, collegiale e goliardica. Perché alla fine il cinema, come la vita, a volte è un circo, un varietà di marcette e udienze pontificie e idoli vecchi e nuovi e siamo un po’ tutti borghesi e provinciali, mentre scordiamo l’autenticità per inseguire i miti.