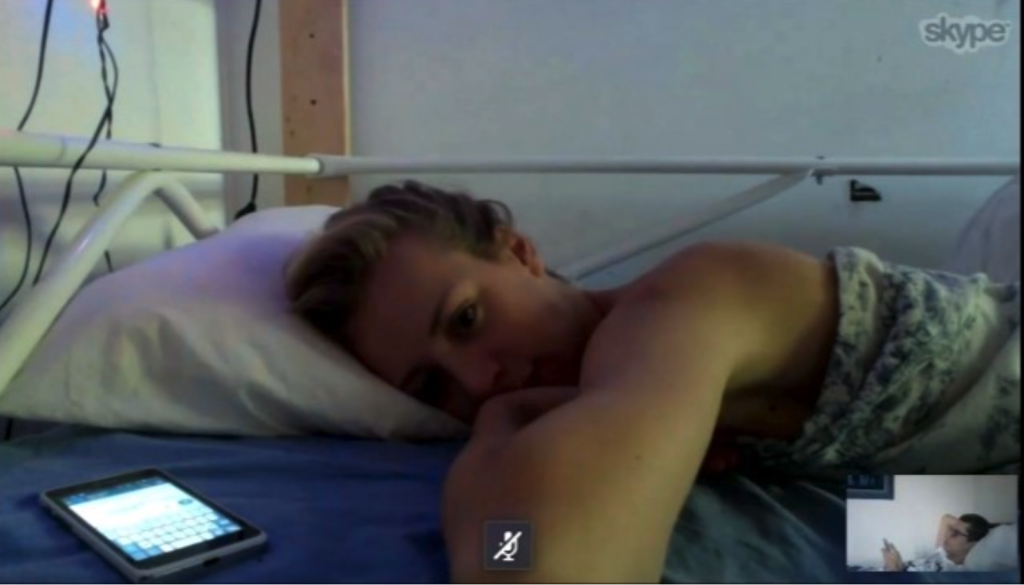Alice Ambrogi, 24 anni, pensa che il cinema debba essere politico oggi più che mai, e se racconta storie a volte grottesche ed esasperate è per far capire a tutti che la realtà spesso è diversa da quello che sembra. Ha firmato la regia e la sceneggiatura di Farfalle nello stomaco, un cortometraggio grottesco che vede come protagonista Marcello Fonte e SPOGLIATI, documentario che narra le vicende della Kiki House of Windowsen e lo scenario della Ballroom italiana. Baby Moon Park, il suo lavoro finale alla RUFA, è distribuito da Première Film ed è stato selezionato in numerosi festival tra i quali il Giffoni Film Festival e Visioni Italiane.
Hai trovato nell’estetica grottesca la tua dimensione: quale percorso hai seguito per arrivarci?
L’idea per Farfalle nello stomaco è nata da un connubio insolito: da un lato avevo visto da poco Il pasto nudo di Cronenberg, dall’altro ero affascinata da una leggenda orientale che riguardava il mondo delle farfalle. Baby Moon Park invece è un progetto molto più personale, ho voluto raccontare qualcosa di me e delle persone a me care insieme a qualcosa di creato solo dalla mia immaginazione. Ho così dato vita a un mosaico di storie che, seppur esagerato, risultasse reale e credibile. In generale, il mio processo creativo inizia immaginando un personaggio, che poi studio a fondo per diventarne amica e conoscere tutto di lui: le abitudini, le fissazioni, le paure, i segreti, i sogni e i desideri, soprattutto quelli di cui si vergogna. Solo dopo averlo compreso appieno metto a fuoco la storia. Esaspero la realtà per renderla visibile agli occhi più distratti e annoiati. Questa esagerazione mi permette di catturare l’attenzione del pubblico, talvolta anche disturbandolo, svelando così aspetti della condizione umana attraverso una lente deformante che, paradossalmente, li rende più autentici.
SPOGLIATI è un documentario che narra le vicende della Kiki House of Windowsen e lo scenario della Ballroom italiana tra il 2021 e il 2023, spaziando tra Roma, Napoli e Milano. Cosa ti ha portato da Gian, Morgan, Sasha e Concetta e perché hai deciso di raccontare le loro storie?
Aver avuto la possibilità di girare un documentario che pone al centro le vite, le difficoltà di affermazione e posizionamento sociale della comunità LGBTQIA+, non è stato solo necessario ma doveroso. Ha significato poter fornire una testimonianza di come la conquista dei diritti non si attui solo attraverso lo schermo di un telefono, ma la si faccia camminando, performando, mettendo in scena un mondo parallelo in cui la lotta è forse superata, ma resta fondamentale come memoria storica e sociale. Non solo, con SPOGLIATI ho voluto evidenziare l’urgenza di rivendicare la proprietà che ognuno ha del proprio corpo inteso come strumento politico, performativo, fluido e indipendente con il quale si possono sovvertire le regole imposte da una società patriarcale ed eteronormativa che non è più possibile accettare. Le storie di Gian, Morgan, Sasha e Concetta sono l’emblema di questa urgenza. Ognun* di loro ha una storia complessa alle spalle, ognun* di loro è stat* vittima di hate crimes, ognun* di loro ha lottato incessantemente senza mai mollare, ognun* di loro ha trovato una rinascita e un senso di rivalsa all’interno della Ballroom, scoprendo una comunità forte e accogliente. Chi meglio di loro, allora, per raccontare questa storia?

Preferisci creare un legame o mantieni una certa distanza dai soggetti dei tuoi lavori?
In quanto regista, ritengo essenziale sviluppare sempre un rapporto di amicizia basato sulla totale fiducia reciproca con i protagonisti delle storie che racconto. Per narrare una storia in maniera autentica e credibile è fondamentale che i soggetti si sentano a loro agio davanti alla telecamera. Prima di iniziare le riprese di un documentario occorre trascorrere del tempo con i propri soggetti, senza camere né troupe, imparando a conoscersi e sviluppando un rapporto intimo. Bisogna raccontarsi gradualmente e io devo a mia volta dare qualcosa: per guadagnare la loro fiducia devo aprirmi io per prima, mostrandomi vulnerabile e sincera. Solo così si può ottenere un dialogo trasparente e autentico quando le telecamere poi si accendono. Con i/le ragazz* della Kiki House of Windowsen non è stato difficile, ci siamo compresi fin dal primo momento in cui abbiamo iniziato a parlare. Credo che quello che ci legato di più è stato condividere lo stesso obiettivo, ma anche la stessa rabbia e sete di rivalsa. Avevamo tutt* il desiderio di urlare: “Siamo qui e non ce ne andiamo. Guardateci, notateci, rispettateci!”.
Ti senti più a tuo agio con la fiction o la non fiction?
È una domanda che ultimamente mi sono posta spesso. Devo ammettere, non senza vergogna, che quando ho iniziato il mio percorso non avrei mai immaginato di appassionarmi al documentario, che ritenevo un valido ripiego solo nell’eventualità di un fallimento nel cinema di finzione. Ero convinta che l’unica “essenza” del documentario fosse quella informativa ed educativa, ignoravo l’esistenza di una potente componente artistica, poetica e simbolica. Dire che mi sono ricreduta sarebbe riduttivo: barcollavo nella totale ignoranza di un luogo così ricco d’inventiva, così libero da ogni schema prestabilito, un mondo fluido e accogliente nel quale poter riversare la mia creatività.
Baby Moon Park è la storia di Violante, una giovane donna che lavora in un parco giochi e vive una crisi in seguito a un aborto. Ne racconti le varie le contraddizioni, il trauma e soprattutto le scelte. Pochissimi corti affrontano questo tema, soprattutto con il clima politico attuale che preferisce una narrazione a senso unico.
Quando ho iniziato a scrivere la storia di Violante, non sapevo ancora che avrei raccontato la storia di un aborto. La mia priorità era creare una narrazione che ingannasse lo spettatore, costringendolo a contraddirsi e a riflettere sui suoi pregiudizi. Volevo dar vita a un personaggio che al principio venisse etichettato come un mostro, qualcosa contro natura. Perciò dovevo trovare un espediente narrativo che portasse ogni mente benpensante a concordare con un giudizio così estremo. Viviamo in una società che ha un forte pregiudizio nei confronti delle donne che scelgono di non avere figli: quando una donna decide di non averne, viene spesso considerata incompleta o egoista poiché si allontana dall’idea convenzionale della femminilità. Così, ho deciso di creare Violante, una donna che odia suo figlio, o almeno questo è ciò che sembra. Con il progredire del corto, però, il pubblico si ritrova inevitabilmente a empatizzare con la stessa donna che pochi minuti prima aveva disprezzato, scoprendo che la realtà è più complessa. Alla fine si svela che Violante non ha mai avuto un figlio. A causa di una scelta molto difficile, ha perso il controllo e – forse per proteggersi da un dolore troppo profondo – si è distaccata dalla realtà. In questo modo conduco il pubblico a empatizzare ulteriormente con la protagonista: lo spettatore è costretto a rivalutare la propria opinione, trasformando colei che all’inizio sembrava un mostro nella vittima di una società giudicante e selettiva.

«Madre è l’anagramma di merda» è una frase che pronuncia Violante parlando con l’amica Sharon.
Io e Clara Greco, l’attrice che interpreta Violante, abbiamo costruito insieme questo personaggio. Siamo partite dalla sceneggiatura per poi cesellare gli ultimi particolari durante le prove precedenti alle riprese. Ho scelto Clara per vari motivi: al tempo aveva poca esperienza sui set cinematografici e un’impostazione più teatrale, ma è comunque riuscita a indossare subito gli abiti di Violante dimostrando un talento sconcertante. Mi ricordo ancora una frase che mi ha detto in uno dei nostri primi incontri: «i figli non sono una proprietà, sono qualcosa di autonomo e distinto, a sé stante». Ho capito che Clara era Violante e che la mia ricerca era finita.
Violante indossa una t-shirt che recita: Are you in a film or in reality? Citi Godard, un po’ è uno scherzo e un po’ è metacinema?
La scelta della maglietta è avvenuta quasi per caso. La costumista me l’ha proposta e io ho accettato, l’ho trovata buffa e adatta. Solo dopo, a corto non solo girato ma anche post-prodotto, mi sono resa conto del significato simbolico della scritta. Violante sta male, persa in un delirio che non le permette di distinguere la realtà dalla finzione. Quale maglietta poteva essere più appropriata per esprimere un concetto simile? L’obiettivo del corto è proprio quello di invitare lo spettatore a essere più clemente e paziente nell’esprimere un’opinione, perché spesso la realtà non è come sembra. E poi, cos’è la realtà? Quali sono i parametri per riconoscerla?
Il tuo lavoro sembra essere soprattutto politico, militante: parli di aborto, dell’abolizione del Ddl Zan, di salute mentale, di diritti. Credi che sia possibile fare cinema politico oggi?
Ho sempre considerato il cinema non solo come un mezzo di intrattenimento, ma anche e soprattutto come uno strumento di espressione accessibile a tutti, indipendentemente dall’estrazione sociale e dal livello di istruzione. Il cinema offre la possibilità di condividere pensieri e idee, dunque quale strumento migliore per parlare di diritti? Credo che oggi più che mai sia non solo possibile ma necessario fare un cinema militante, affrontare temi legati all’urgenza di un cambiamento politico e sociale. Credo sia più facile farlo in un contesto indipendente, dove non ci sono vincoli e si è liberi di esprimere le proprie idee senza scendere a compromessi. Molti registi hanno paura di compromettere la propria carriera e, da un punto di vista meramente egoistico, è sicuramente più facile chinare la testa e restare in silenzio. Non nego che un po’ invidio chi riesce a farlo e a essere in pace con sé stesso, è qualcosa che io non sono mai riuscita fare.
Hai collaborato spesso con Luca Martella, mostrando grande attenzione verso la musica. Quanto è importante l’originalità per te?
Per me la musica e il suono in generale sono la colonna portante del cinema. Rappresentano quell’elemento senza il quale il cervello umano faticherebbe a dissociarsi dal mondo reale e lasciarsi trasportare in un nuovo universo. L’importanza dell’originalità della colonna sonora dipende dalle esigenze narrative del progetto su cui sto lavorando: ad esempio in SPOGLIATI, trattandosi di un documentario che racconta di una comunità, sarebbe stato fuori luogo alterare le musiche che hanno contribuito a formarne la cultura. Ho collaborato con Luca come sound designer su ogni mio progetto e in Baby Moon Park si è occupato anche della creazione delle musiche originali. Abbiamo lavorato a lungo su questo aspetto: inizialmente faticavamo a trovare il giusto equilibrio tra le mie influenze post punk e le esigenze narrative del corto che richiedevano invece qualcosa di più mistico e trascendente, capace di guidare il pubblico attraverso l’arco narrativo della storia. Il compromesso è stata la traccia con cui il corto si chiude, fortemente ispirata a Inno del perdersi dei Verdena. In generale, credo che la parola chiave in una collaborazione artistica sia proprio questa: empatia. Senza, è impossible lavorare insieme in modo efficace.
Quando lavori ai tuoi progetti hai un target preciso in mente?
Il pubblico che preferisco raggiungere e con cui ho un riscontro più significativo sono le persone che incontro per strada, al ristorante, al bar, in piazza, la gente comune. Con SPOGLIATI il mio obiettivo era raggiungere i membri della comunità LGBTQIA+ che sono quotidianamente vittime di oppressione, hate crimes, discriminazione. Volevo raggiungere le persone che hanno bisogno di una comunità per sentirsi accettate e protette e che forse non sanno nemmeno che ne esiste una per loro. Per questo motivo ho proiettato il film in ogni centro sociale e Circolo Arci che si è mostrato interessato, soprattutto per raggiungere i giovani.
Fra poco uscirà il tuo nuovo progetto, un docufilm in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell’ASL Roma 1.
Con il dottor Gianluigi Di Cesare ci siamo posti l’obiettivo di esplorare il delicato tema della salute mentale nei giovani, sfidando i pregiudizi sociali e combattendo le narrazioni erronee che spesso vengono associate all’argomento. Nel film affrontiamo diversi temi: dagli ostacoli che nascono dalla mancanza di comunicazione intergenerazionale alla paura del giudizio sociale e molto altro ancora. A mio avviso, una delle particolarità di questo progetto è che sia stato realizzato interamente da under 30. I protagonisti del film hanno un’età che spazia dai 16 ai 23 anni e la fantastica squadra che ho formato è altrettanto giovane, nessuno di noi supera i 27 anni. La trovo una cosa bellissima.
La versione completa di questo articolo è apparsa su Fabrique du Cinéma n. 44. Abbonati qui per restare sempre aggiornato sulle novità del cinema italiano.




























 Spesso l’attenzione del pubblico è del tutto focalizzata sulla persona che commette il crimine, soprattutto nel caso dei serial killer: ci si concentra sul loro passato, sul modus operandi e sul fascino che alcuni di loro hanno saputo esercitare durante le indagini e i processi. Non a caso uno dei rischi principali di chi tratta il genere come storyteller è la romanticizzazione del crimine e la mitizzazione dell’assassino, come è accaduto nel caso di Jeffrey Dahmer dopo la serie di Ryan Murphy per Netflix. Ma la vicenda del Cannibale di Milwaukee ha portato anche a una riflessione razziale, sull’impunità che gli è stata a lungo garantita dall’essere bianco e benestante. Analogamente al criminale per cui il mondo dell’intrattenimento ha sfiorato l’ossessione, Ted Bundy, interpretato tra gli altri da Zac Efron nel film Ted Bundy – Fascino criminale, che puntava l’accento su quanto il serial killer fosse di bell’aspetto.
Spesso l’attenzione del pubblico è del tutto focalizzata sulla persona che commette il crimine, soprattutto nel caso dei serial killer: ci si concentra sul loro passato, sul modus operandi e sul fascino che alcuni di loro hanno saputo esercitare durante le indagini e i processi. Non a caso uno dei rischi principali di chi tratta il genere come storyteller è la romanticizzazione del crimine e la mitizzazione dell’assassino, come è accaduto nel caso di Jeffrey Dahmer dopo la serie di Ryan Murphy per Netflix. Ma la vicenda del Cannibale di Milwaukee ha portato anche a una riflessione razziale, sull’impunità che gli è stata a lungo garantita dall’essere bianco e benestante. Analogamente al criminale per cui il mondo dell’intrattenimento ha sfiorato l’ossessione, Ted Bundy, interpretato tra gli altri da Zac Efron nel film Ted Bundy – Fascino criminale, che puntava l’accento su quanto il serial killer fosse di bell’aspetto.




 Le cose che ci passano per la mente sono quasi sempre inconfessabili, il voyeurismo di Matilde, la sua difficoltà nel lasciar andare, ci mettono di fronte alla sua ferita. Il tuo è un cinema intimista, fatto di sentimenti quotidiani e cose minuscole. Cosa aspiri a raccontare e in quale forma?
Le cose che ci passano per la mente sono quasi sempre inconfessabili, il voyeurismo di Matilde, la sua difficoltà nel lasciar andare, ci mettono di fronte alla sua ferita. Il tuo è un cinema intimista, fatto di sentimenti quotidiani e cose minuscole. Cosa aspiri a raccontare e in quale forma?